Dalla Grecia a oggi: "Le Olimpiadi moderne sono un misto di gioco, spettacolo e affari"
CUNEO
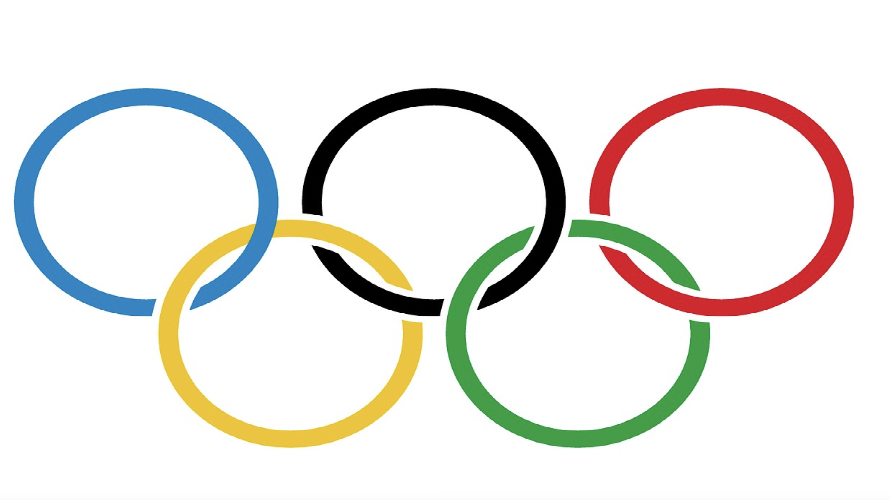
PIERCARLO BARALE - Le olimpiadi di Mosca nel 1980 vennero boicottate da settanta nazioni, compresi gli Stati Uniti, gli ideatori del boicottaggio. Furono un flop, anche se aprirono il mondo sovietico sclerotizzato ai turisti, giornalisti, atleti di mezzo mondo. Era il tempo in cui, con un pacco di calze di nylon, si poteva soggiornare in albergo per un mese. L’Urss aveva invaso l’Ungheria, paese satellite dell’Impero sovietico, allontanatasi dall’ortodossia comunista. Venne ricondotta sulla retta via dai carri armati, lasciando sul campo 2500 cadaveri di liberati. I giochi olimpici erano già stati funestati a Monaco di Baviera – 1972 – con l’assalto di terroristi palestinesi negli alloggi degli atleti israeliani. L’intervento sconsiderato ed avventato delle teste di cuoio tedesche fece più danni degli stessi sequestratori. Fino alla defenestrazione di Gorbačëv, al quale si deve la caduta del muro – 1989 -, la bellicosa politica comunista staliniana e dei successori tenne sotto dura mano parte dell’Europa e vaste aree dell’Asia. Le olimpiadi di Mosca avrebbero dovuto essere una vetrina per il governo. Il boicottaggio orchestrato dagli Usa lo impedì. Si sentiva però che il regime era al collasso. A succedere ai fondatori ora imbalsamati al Cremlino è arrivato Putin, che ha intrapreso la guerra lampo – così la riteneva erroneamente – contro l’Ucraina, cercando il bis verificatosi per l’Ungheria e la Cecoslovacchia le cui ribellioni erano finite nel sangue. Anche per questo, lo spirito delle olimpiadi non aleggiò su Mosca nel 1980.
I giochi olimpici iniziarono ad Olimpia, in Grecia – gli Usa di allora -. Non a Maratona, la località dove Atene, distante 42 chilometri, aveva battuto Serse, re della Persia. Era giunto con una flotta sterminata per sottomettere la più importante città stato della Grecia. Era l’anno 490 a.C.. Dopo la battaglia, vinta dal generale Milziade, si contarono 400 morti persiani e 192 greci. Da allora, in onore dell’ateniese che aveva corso senza sosta i 42 chilometri e 800 metri per annunziare la vittoria, nei giochi fu inserita la gara di corsa sul medesimo percorso. La gara regina è sempre stata la corsa chiamata stadion di 178 metri – praticamente i nostri 100 – seguita da quella chiamata diaulos, il doppio stadio, cioè i nostri 400 metri. Quella più spettacolare era la quadriga, tethrippon, su carro a due ruote tirato da quattro cavalli, con 12 giri di pista, che misurava circa 400 metri. Ricorda Pindaro che in una delle accesissime gare partirono 41 carri e ne restò uno solo, il vincitore. Dietro di lui, nessuna quadriga in vista, in quanto tutte si erano schiantate nei rituali dodici giri, circa cinque chilometri. Soltanto ruote ancora in movimento, cavalli sciolti o a terra. Sovente succede alla partenza delle nostre gare automobilistiche. Non c’era da loro la safety car per rimettere in fila i contendenti e far ripartire la gara.
Le prime olimpiadi risalgono al 763 a.C. e si susseguirono ininterrottamente, ogni quattro anni, fino all’editto dell’imperatore Teodosio, emanato nel 393 d.C.. Furono 293 e lo spazio tra l’una e l’altra costituì una sorta di calendario, utilizzato come tale. Omero nell’Iliade riferisce ampiamente dei giochi ed in particolare di quelli che solennizzarono morti eccellenti, eroi, con gare alle quali parteciparono i migliori atleti della Grecia e delle colonie della Magna Grecia, site nel sud dell’Italia. Parteciparono sempre per vincere, addirittura con ogni mezzo. Talvolta illecito, con accordi, truffe, violenze, che portarono spesso lottatori e pugili alla morte. La vittoria dava lustro in tutta la Grecia e la sconfitta non era indolore. Lo storico greco Pindaro scrive che lo sconfitto torna vergognoso, per strade nascoste. Pindaro si trova in totale contrasto con il noto detto del marchese De Coubertin, ritenuto il padre delle olimpiadi moderne: "L’importante non è vincere, ma partecipare”. Affermava Pindaro che "con ogni mezzo bisogna annientare il nemico". Secondo De Coubertin, i giochi devono essere uno spettacolo e le competizioni devono essere impostate a correttezza, solidarietà. Auspica addirittura una sorta di fratellanza tra popoli e nazioni, indipendentemente dalla provenienza degli atleti, dal colore della pelle. Il barone francese pare non abbia compreso lo spirito di Olimpia, quello originario. Oppure ha voluto riportare un po’ di pace tra le nazioni dopo la spaventosa battaglia di Sedan – 1870 -, che aveva profondamente diviso l’Europa e coperto di cadaveri, prevalentemente francesi, il campo di battaglia, vinta dai prussiani.
Nelle gare delle olimpiadi moderne – la prima risale al 1896 – si è fatto avanti il doping, non la correttezza. Anche nelle olimpiadi antiche gli atleti diventarono professionisti, ricevendo regali sontuosi. Ancora Plutarco narra che nei giochi del 388 a.C. Eupolo di Tessaglia vinse il premio di pugilato, comprando ben tre avversari. Ricorda pure un fatto che fece scalpore, quando si doveva vincere ad ogni costo e con qualunque mezzo. Durante una gara di pancrazio – un misto di lotta e pugilato –, un contendente aveva afferrato un piede dell’avversario, che lo stava strangolando con un braccio. In preda a dolori fortissimi, alzò l’indice in segno di accettazione della sconfitta. Purtroppo, la controparte era già morta strangolata. Le olimpiadi moderne sono un misto di gioco, spettacolo, affari, professionismo ed alto dilettantismo. Pochi vi partecipano senza ottenere qualche profitto. In base all’impostazione di De Coubertin, solo i dilettanti avrebbero potuto prendervi parte, senza competere a suon di doping e di compensi. Ad Olimpia si andava solo per vincere, non per partecipare. La sconfitta non era a livello del vae victis dei romani, il noto pollice verso dell’imperatore per i perdenti nel Colosseo.
Da noi gli atleti vincenti nelle specialità più seguite, possono ottenere ingaggi pubblicitari milionari, mai però simili a quelli dei calciatori professionisti. L’atletica non arricchisce, salvo gli atleti eccezionali. Di positivo rispetto alle olimpiadi antiche c’è che si è sicuri di non venire strangolati dall’avversario. Dopo Monaco e la strage di atleti israeliani, le olimpiadi sono blindate per quanto riguarda i partecipanti ed anche gli spettatori. Con ogni mezzo – anche tecnologico – legioni di specialisti nella difesa proteggono gli atleti durante le gare e la permanenza, soffocando talvolta il desiderio del pubblico di trovarsi a contatto con i loro idoli. Per documentarmi ho letto il libro “Da Olimpia a Rio de Janeiro. L’importante è vincere”, autori Eva Cantarella ed Ettore Miraglia ed editore Feltrinelli 2016. Ho riletto le parti dell’Iliade ed alcune parti di trattati storici di autori greci sul punto.
Piercarlo Barale





