Dalla diversità di linguaggio non deve nascere il razzismo!
CUNEO
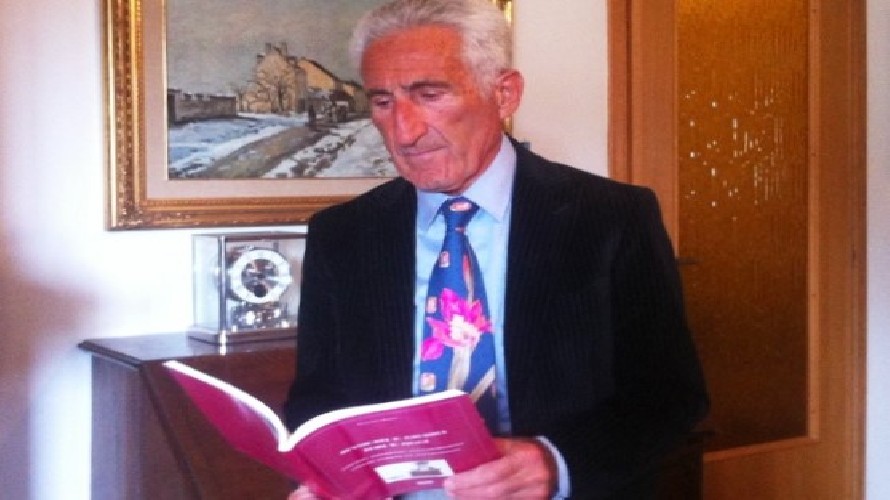
PIERCARLO BARALE - Octavio Paz, premio Nobel per la letteratura, riferendosi al legame tra corruzione e società, afferma: "Quando una società si corrompe, la prima cosa che va in cancrena è il linguaggio. La critica della società, di conseguenza, inizia con la grammatica e con la restaurazione dei significati". Nel periodo di maggiore fortuna del regime fascista - 1938 - l'intellettuale Bruno Cicognani, in un elzeviro pubblicato su Il Corriere della Sera, propose l'abolizione dell'uso del "lei" a favore del "voi", sostenendo che in tal modo si sarebbe posta fine ad una "aberrazione grammaticale e sintattica". Ci si rivolgeva ad una entità estratta, anziché a "una persona reale, corporea e vivente".
In buona sostanza, l'intellettuale, con una singolare interpretazione del significato del "lei", che veniva utilizzato impropriamente pur volendosi riferire ad un "lui", corroborò l'intendimento mussoliniano. L'uso del "voi" venne prescritto agli italiani ormai in gran parte storditi dalla propaganda ed assenzienti alle teorie fasciste. Per i nati nel regime, prima balilla poi avanguardisti, non vi fu bisogno di affossare il "lei". Come i nativi digitali e millennial di oggi, avevano già assimilato le imposizioni. Tutto accettato e condiviso di buon grado, mentre gli storici antifascisti in ogni parte della penisola - pochi ma buoni - se ne fecero beffe.
Il Duce, nella creazione di una nuova società, agì anche nei confronti della lingua, così staccando soprattutto i giovani dagli schemi significati preesistenti. E non solo con interventi di rettifica del valore dei pronomi, il ritorno alla scrittura ed alla numerazione romaneggiante, ancora visibile su edifici storici, divenuti, se sopravvissuti alla guerra, monumenti tutelati. Alcune scritte inneggianti al Duce, in ogni parte della penisola, sono rimaste inalterate. Forse grazie alla eccellente qualità delle vernici, alla loro perfetta utilizzazione ed alla preparazione delle pareti destinate a tale ricordo perpetuo.
Sono stato incuriosito dalla recensione del novo libro di Andrea Moro, professore di linguistica generale alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, già autore di numerosi libri divulgativi. E' titolato "La razza e la lingua - Sei lezioni sul razzismo" - Edito da La nave di Teseo, in questi giorni è in libreria. Dalla lettura ho tratto come conoscenze circa l'origine delle lingue, la dipendenza dalla genetica, le nuove frontiere alla luce della comparazione tra le stesse; le comuni origini delle lingue indoeuropee.
Non esistono, secondo l'autore, lingue migliori di altre; più semplici o più complesse; più musicali o più aspre; che permettono la nascita di filosofia, scienza e letteratura e lingue che invece rendono difficile l'estrazione; lingue più evolute o lingue primitive. Non sono le lingue ad arricchire coloro che le utilizzano, ma le opere scritte da autori che ne fanno mezzo per comunicare le loro sensibilità, aprendo così la mente dei lettori. I nativi in ogni parte del mondo apprendono la lingua del luogo, così come imparano a camminare o a mangiare. Fino alla pubertà è facile e rapida la conoscenza di lingue nuove. Con l'età matura il processo di apprendimento appare difficile e lungo, perché avviene con la partecipazione della ragione e la comparazione con la lingua madre.
Sulle caratteristiche del linguaggio sono state create artificiosamente differenze, con la considerazione negativa di quelle dei nativi d'America o Australia, con riferimento al colore della pelle o al livello di civiltà, misurate secondo criteri del mondo occidentale. La saccenza britannica ha dovuto rimangiarsele, tali considerazioni, che portavano ad una inferiorità razziale delle colonie dell'India. Si sono resi conto che ben prima dell'era cristiana in India furono scritti poemi, opere filosofiche di enorme profondità di pensiero e precisione lessicale e sintattica. Allora inserirono anche l'India tra i "buoni" e crearono l'espressione lingue indoeuropee, mentre in precedenza si ritenevano elitarie solo quelle derivate dal greco e dal latino.
Piercarlo Barale





